
|
Studio Maddalena Carioni Nel periodo compreso fra il 6 Aprile 1972 e gli inizi di Giugno del 1973, lo Studio Maddalena Carioni inaugurava la sua attività, organizzando una dozzina di eventi che suscitarono grande interesse sulla scena milanese, per poi chiudere definitivamente i battenti prima dell'estate. |
|
 |
|
|
Così come parzialmente archiviati a futuro oblio sono quegli anni '70 che costituivano lo sfondo insostituibile di questa vicenda.
Per ragioni di connessione con altri eventi che richiameremo nel corso della narrazione, e di considerazioni che è possibile fare soltanto oggi, penso sarà più opportuno procedere secondo una ordinata scansione cronologica.
| |
|
La mostra che aprì l'attività della Galleria fu quella dedicata a Fernando Tonello, un artista allora emergente che purtroppo, dopo un breve periodo di successo, sarebbe morto appena trentaduenne nel 1975. Questa mostra costituiva, da parte dell'artista, la svolta definitiva dal suo primo periodo postPop ad un lavoro più concettualizzato, basato però tuttavia in gran parte, in questo periodo in cui circolavano solo statements in inglese, su scritte in latino -lavoro peraltro già annunciato l'anno prima con una mostra alla Galleria Toselli. La scelta della frase, insieme alla soluzione iconica prescelta proponevano l'idea dell'opera come “illustrazione” nel senso più alto della parola. Il titolo della personale allo Studio Carioni era la declinazione della parola res: Res Rerum Rebus, ecc. Il 4 maggio successivo seguì una personale dell'artista abruzzese Alessandro Jasci. L'artista lavorava allora sul tema dell'autobiografia con un ventaglio di scelte operative di tipo concettuale: scritte, disegni, fotografie. La mitologia dell'artista-demiurgo come centro dell'opera obbediva in realtà più che ad esigenze autobiografiche ad una specie di cortocircuito tautologico che ribadiva il tema, cenrale in quegli anni, dell'arte come autovalore, come mitologia autoreferenziale. Il 25 dello stesso mese la Galleria proponeva una collettiva che tracciava una sorta di dichiarazione di intenti. Vi partecipavano infatti Luciano Fabro, Mario Fusco, Jasci e Tonello, Hidetoshi Nagasawa, Mario Nigro e Remo Salvadori, Antonio Trotta e Zvi Goldstein. Basterebbe infatti notare come fra gli invitati si trovi già contenuto il nucleo del futuro “Miracolo a Milano”, che sarebbe stato celebrato nel 1975 dalla rivista Data, di Tommaso Trini, con tanto di copertina: il gruppo, qui ancora in decantazione, conta le presenze di giovani emergenti che avrebbero potuto virtualmente farne parte, come Jasci e Salvadori. E' interessante, in questo senso, il ruolo di Fabro, che all'epoca aveva già la statura di un giovane caposcuola: schivo e molto selettivo, non partecipava volentieri a mostre collettive che non fossero quelle del gruppo di Arte Povera, o esposizioni che non avessero rilevanza internazionale. Segno evidente che il contesto qui ipotizzato lo interessava. Sono significativi in questo senso, allora, anche i nomi di Nigro e Zvi: il primo un pittore già non più giovane, di cui Fabro aveva però molta stima; così come apprezzava il giovane concettualista israeliano Zvi Goldstein, in seguito tornato in patria e quindi uscito dall'ambiente milanese. Dopo la pausa estiva, l'attività riprende solo il 19 Ottobre con la mostra “Lo spazio fra me e l'opera” di Antonio Trotta, credo una delle più interessanti per definire lo spirito di quel particolare momento milanese. Trotta che in seguito ha caratterizzato il suo lavoro soprattutto come scultore, esponeva in quest'occasione una serie di tele emulsionate il cui soggetto erano le tele esposte stesse: in “Pampero”, ad esempio, nello spazio di un trittico, compariva l'immagine di un secondo trttico con le tre tele barrate da una striscia di pittura spruzzata (naturalmente solo fotograficamente): anche le tele “vere” erano barrate da una “vera” striscia di colore verde, come a suggerire che prima che l'artista spruzzasse il colore, all'interno del trittico fosse già presente l'idea di quest'azione. Non solo l'idea precede l'azione, ma in qualche modo l'opera sembra contenere se stessa, l'oggetto reale corrisponde ad un oggetto ideale preesistente. La serie delle "mostre" continua, il 16 Novembre, con la performance di Jorge Eielson, un artista peruano che godeva allora di una celebrità assai estesa. Riallacciandosi ad una antica tradizione della sua terra Eielson creava delle tele monocrome che facevano da sfondo a nodi di tessuto che oltre a costituire la struttura formale di ogni tableau si richiamavano all'antica “scrittura di nodi” delle popolazioni precolombiane. La performance dell'artista allo Studio Carioni ebbe luogo in concomitanza con la mostra dei suoi tableaux alla Galleria Lorenzelli in Milano. In Dicembre lo Studio Maddalena Carioni chiudeva l'anno con una seconda collettiva che segna contemporaneamente un'estensione della collettiva di Maggio, ed anche una specie di censimento, un “ritrovarsi” di artisti, questa volta non solo a livello milanese, ma nazionale e internazionale. Infatti oltre ai partecipanti della prima collettiva (salvo Zvi) c'erano Anselmo, Bagnoli, Boetti, Luethi, Mambor e Mattiacci, Paolini e Penone, Salvo, Dorothée Von Windheim, Zaza, Zini e Zorio. In pratica erano presi in considerazione i due poli dell'effettiva dinamica culturale italiana di quegli anni, Milano (il gruppo già evidenziato) e Roma (con Mambor e Mattiacci), e naturalmente il terzo polo torinese con una notevole presenza di artisti dell'Arte Povera (Anselmo, Boetti, Paolini, Penone e Zorio), e anche l'outsider Salvo, allora non ancora “pittore”. Gli artisti stranieri qui citati, erano allora molto presenti in Italia - la Von Windheim vi risiedeva. Ma Luethi (con Zaza) poteva allora anche rappresentare una svolta nell'uso della fotografia, allora più che altro circolante nella versione “fredda” concettuale e postconcettuale, e nell'opera di entrambi piegata al contrario ad esigenze narrative più emotivamente coinvolgenti. Vedremo poi come questo vasto programma si sarebbe riconfermato, in qualche modo, nelle mostre successive. Il 18 Gennaio 1973, Maddalena Magliano inaugurava il secondo anno di attività del suo Studio con una personale di Franco Ravedone, un artista molto interessante, destinato anche lui, purtroppo, ad una tragica fine: se non proprio prematura, abbastanza precoce da impedire una piena valutazione del suo lavoro, che negli ultimi anni sembrava aver raggiunto una notevole maturità. All'epoca Ravedone lavorava soprattutto con video e foto, portando avanti una sua battaglia, amara e polemica, sull'arte, la critica ed il mercato. Il primo di Febbraio seguiva una personale di Valentino Zini, accompagnata da un asciutto catalogo, con uno scritto dell'artista-critico romano Tullio Catalano, nel suo testo si situa Malevic: tuttavia, nella Milano ancora rivitalizzata dalla presenza di Vincenzo Agnetti, non si poteva non cogliere una sfumatura postmanzoniana nelle opere presentate, con le loro composizioni basate su equilibri a croce o a scacchiera: una scelta formale contemporaneamente elementare ed eletta, come in Malevic. Varrebbe la pena di ricordare che Zini era reduce da una serie di tre mostre tenute da Massimo Mainini a Brescia, da Pio Monti a Macerata e alla GAP di Roma (la galleria di Tullio Catalano) in cui aveva presentato una serie di tele emulsionate con parole composite tutte dal greco antico (come "pseudosofia"). La caratteristica di queste parole così particolari era appunto di essere state usate - una volta sola - in tutta la lettura del tempo (da cui il titolo: Apox) Questa mostra sarebbe stata forse ancora più vicina al senso del lavoro del gruppo milanese. Il 22 Febbraio aveva luogo una seconda mostra di Alessandro Jasci, con tele emulsionate tratte da una performance sui sogni. Il primo Marzo lo Studio ospitava lo spettacolo teatrale “Lollia Paolina”, una produzione: mobile action artist's foundation, con gli attori-autori Ulla Alasjarvi, Beppe Bergamasco, Antonello Mendolia. Il 20 Marzo ebbe luogo una delle più interessanti personali organizzate dalla Galleria, “Alla corte di Re Cremisi” di Giancarlo Croce, un artista romano probabilmente segnalato da Tonello. Dopo un inizio all'insegna del concettuale più freddo (con opere basate sul concetto di tautologia, come una telecamera che riprende se stessa), con questa mostra virava verso una direzione inattesa, più fastosa, neorinascimentale. Vi erano infatti ritratti di personaggi dell'ambiente artistico, o dell'entourage dell'artista, rappresentati in pose e con un abbigliamento, o acconciatura, che potevano richiamare i ritratti del primo cinquecento. Come nel caso di Tonello, si trattava di far coincidere un contenuto con un'idea di forma eletta, che aveva già raggiunto il suo punto più alto e che, in certo senso, andava più “allusa” che imitata. Il 4 Aprile, la mostra dedicata a Mario Nigro si apriva, significativamente, con un autoritratto figurativo del 1940, per svilupparsi poi con una scelta molto rigorosa di tele dal 1968 al 1973, tutte basate sull'alternanza di aste inclinate di vari colori: un percorso all'insegna della semplificazione e dell'essenzialità che anticipava le soluzioni più attuali di una forma di espressione basata su elementi formali essenziali e tipici del linguaggio stesso dell'arte: non più imitazione della natura, ma vocabolario di segni inventati dall'uomo, e piegati ad una sua idea di armonia. La mostra di Athos Ongaro (3 Maggio '73) fu l'ultima che lo Studio avrebbe presentato, prima della chiusura definitiva, che avvenne nel mese di Giugno, improvvisamente: una chiusura che avvenne per motivi extrartistici, non ancora prevedibili all'inizio di Maggio. Ongaro presentava delle formelle quadrate di marmo politissimo, su cui lievissimi affioramenti suggerivano la presenza di forme, tanto in positivo quanto in negativo. Ongaro stesso mi aveva confidato che uno dei suoi punti di partenza erano state le “Nature” positive/ negative di Fontana. Fontana aveva costituito peraltro un motivo di riflessione per tutta quella generazione di artisti, ed in particolare per Fabro. Altre sculture dello scultore toscano erano giocate sulla presenza incongrua di materiali giustapposti, come le cinghie di cuoio dei “sandali”. Vi erano anche alcuni disegni assolutamente evanescenti, che mimavano se così si può dire, lo “strappo” del trucco da un viso, proponendo l'affiorare di maschere appena percettibili, come sotto un velo d'acqua. All'inizio di Giugno lo Studio presentava ancora un libro e alcuni multipli di vincenzo Agnetti. Quest'ultimo evento, il tredicesimo, chiudeva quest'unico anno di attività di Maddalena Magliano, ma anche una vitale ipotesi di lavoro che avrebbe dovuto prendere altre vie.
Un'ipotesi di lettura dei fatti -
Un articolo di Alessandro Jasci, pubblicato da Flash Art nel Luglio 2010, dal titolo “Milano '70- un'occasione mancata”, proponeva una proposta di interpretazione dei fatti di quel periodo, in una chiave abbastanza prossima a quella che io stesso intendevo suggerire a conclusione della brevissima cronistoria della vita e delle mostre dello Studio Maddalena Carioni tracciata più sopra.
Jasci, che fra l'altro generosamente cita un mio “Ricordo di Fernando Tonello” pubblicato da G7 Studio nel 1980, accenna non a caso, allo stesso raggruppamento di artisti da cui sarebbe uscito “Miracolo a Milano”, ma anche, più genericamente, a molti degli artisti presenti nelle due collettive ricordate più sopra, in particolare: Remo Salvadori, Marco Bagnoli, Michele Zaza, Athos Ongaro, Arcelli & Comini, Franco Ravedone, Vito Bucciarelli, come protagonisti di una “possibile” situazione milanese destinata poi in realtà alla frammentazione e alla diaspora. E ancora cita Merz, Agnetti e Nigro come interlocutori abituali, suoi e del progetto dello Studio Maddalena Carioni. Ma il primo per cui vale questo discorso è forse proprio Fernando Tonello, che usava appunto lettere su bronzo montate poi su gesso o altri materiali, a volte con cornici trovate da gessisti o altri artigiani. Per non parlare della pelliccia sintetica usata, proprio nello Studio Carioni, per la “Venere in visone”: una delle colonne della Galleria era stata infatti così “vestita” per ricordare contemporaneamente la “Venere in pelliccia” di Sacher-Masoch e le antiche statue colonnari dell'antica Grecia: forse più Here che Afroditi, chiosavo allora su Nac. Ma per Tonello, era proprio questa continua falsificazione il nucleo stesso dell'operazione artistica: partire da un tema classico, per giungere a Sacher-Masoch, e forse addirittura alla “Venus in fur” dei Velvet Underground, usando peraltro non del vero visone ma una imitazione sintetica. Ricordo che da queste meditazioni sulla necessaria falsità dell'arte nacque poi l'idea di una mostra presso le Scuderie della Pilotta a Parma, curata da Arturo Carlo Quintavalle su nostra sollecitazione. La mostra si chiamava “Della Falsità”(1974) e vi parteciparono Adriano Altamira, Emilio Isgrò, Luciano Fabro, Plinio Martelli, Fabio Mauri, Hidetoshi Nagasawa, Fernando Tonello, Antonio Trotta. Anche qui abbiamo un'ennesima variante sul tema di un possibile raggruppamento che avrebbe portato a “Miracolo a Milano” l'anno successivo.
Ma per tornare all'uso dei materiali, lo stesso Salvadori usava materiali standard (ad esempio cliché fotografici, oltre alla fotografia) per confezionare opere contenutivamente anche più esoteriche di quelle di Tonello o Jasci. Ma anche Nagasawa (in seguito segnalatosi per l'uso più sofisticato di tecniche scultoree legate a materiali come l'oro, il bronzo, il marmo, il legno), nella collettiva del 25 maggio 1972 presentava due targhe di fattura impersonale (“Un punto 23 metri lontano”) confezionate, su progetto, da qualche artigiano.
Per chiudere il capitolo dei materiali tornerei un momento anche sulle foto di Croce, che senza andare a scomodare nessun costumista, usando drappi, pashmine, teli colorati ricreava la sontuosità dei ritratti antichi: i personaggi, spesso con capelli lunghi, barbe o baffi come usava allora, e abiti
“alternativi” per le ragazze, rappresentavano già di per sé una sorta di modernità dell'antico, o antichità del moderno. Varrebbe la pena di ricordare la contemporaneità di queste foto coi tableaux vivants di Ontani e l'incredibile anticipo di entrambe le esperienze con le future opere -tanto per fare un nome- di Cindy Sherman.
Collegarsi alla tradizione era dunque un atto mentale più che artigianale. Un passaggio che tutti gli artisti che abbiamo citato avevano effettuato. E allora: perché questa esperienza che avrebbe dovuto avere un giusto riscontro, se non addirittura successo, non conobbe in realtà un giusto riconoscimento, o si disperse senza lasciare una traccia abbastanza profonda?
Pietrasanta - località in cui tutti loro lavoravano marmo e bronzo - avrebbe potuto diventare un luogo d'incontro fra amici, forse qualcosa di più, ma la scintilla che li aveva uniti a Milano non scoccò più. Ongaro vi realizzò qualche anno dopo le sue sculture a mosaico tridimensionale, e Ravedone si avvicinò per un periodo a Trotta, come mi confessò lui stesso. Tuttavia una diversa ideologia di base impedì che questi momentanei riavvicinamenti ridiventassero un nuovo momento d'incontro. In molti altri casi, l'abbandono di quello che sarebbe potuto diventare il naturale teatro di una nuova entusiasmante esperienza, cioè Milano, favorì la dispersione di quel messaggio che si era visto per un attimo suggerito dallo Studio Carioni. Salvadori e Bagnoli trovarono una certa sintonia in un linguaggio postconcettuale di alto profilo, anche se sostanzialmente lavoravano ognuno per conto suo. Lasciarono Milano anche Jasci e Zvi; morirono nel giro di pochi anni Fusco, Nigro, Agnetti. In pratica, se un tracciato comune avesse dovuto collegare tutti questi punti, questo ormai non era più possibile. Il sogno di una via italiana che sviluppasse le esperienze postconcettuali in un modo assolutamente unico, come opere in linea con una alta tradizione italiana, non divenne mai un contesto operativo condiviso, ma si disperse nelle varie esperienze individuali, con più o meno forza a seconda delle qualità e possibilità espressive, e delle capacità di ogni singolo artista di crearsi un valido supporto economico. Adriano Altamira
Considerazioni critiche e storiche del periodo di Adriano Altamira, leggi l'articolo... |








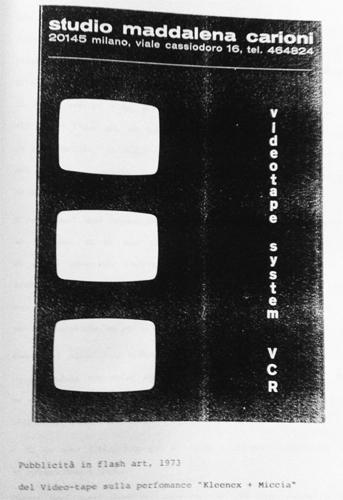
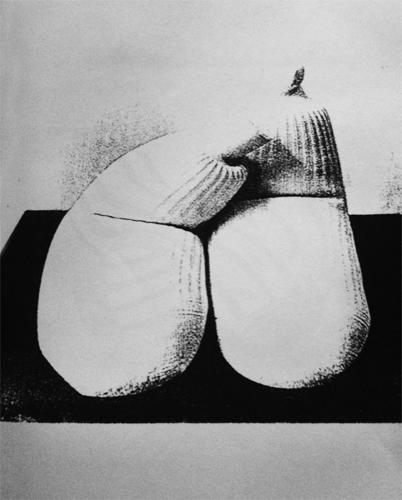











|
studiomaddalenacarioni.com
La galleria Contatti Credits Home
Privacy e Cookie Policy